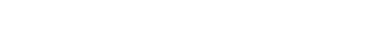La verità sull'apparizione della Madonna a la Salette in Francia
Mi è sembrato opportuno pubblicare l'articolo che avevo scritto nel febbraio del 2019 nel quale sottolineavo come certi prelati usano
"L'arte di affermare per negare"
Credo importate in questo periodo di pazzia bellica, di genocidi di bambini, ricordare il "segreto" della Madonna nell'apparizione de La Salette nel 1846, che non è più segreto perché pubblicato con tanto di imprimatur ecclesiastico, in cui le preoccupazioneni della Madre di Dio assumono un valore terribile di attualità.
Dopo 173 anni dall'apparizione de La Salette, si continua a depredare le coscienze dei cristiani per renderliignari della verità e innocui per chi li inganna.È andata in onda il 2 febbraio 2019 su TV 2000 (emittente televisiva della CEI) la trasmissione “Indagine ai confini del sacro”, nella quale si parlato dei “segreti lasciati dalla Vergine a due pastorelli a La Salette. Già il termini indagine ci aveva fatto pensare a qualcosa di non risaputo, a una ricerca fatta con metodo e con rigore per avere più conoscenza sui fatti de La Salette. Siamo stati sconcertati dalla superficialità e da conclusioni contraddittorie.
Sul Vangelo di Giovanni. Commenti e approfondimenti. Parte Prima
Sul Vangelo di Giovanni
Commenti e approfondimenti
Parte Prima
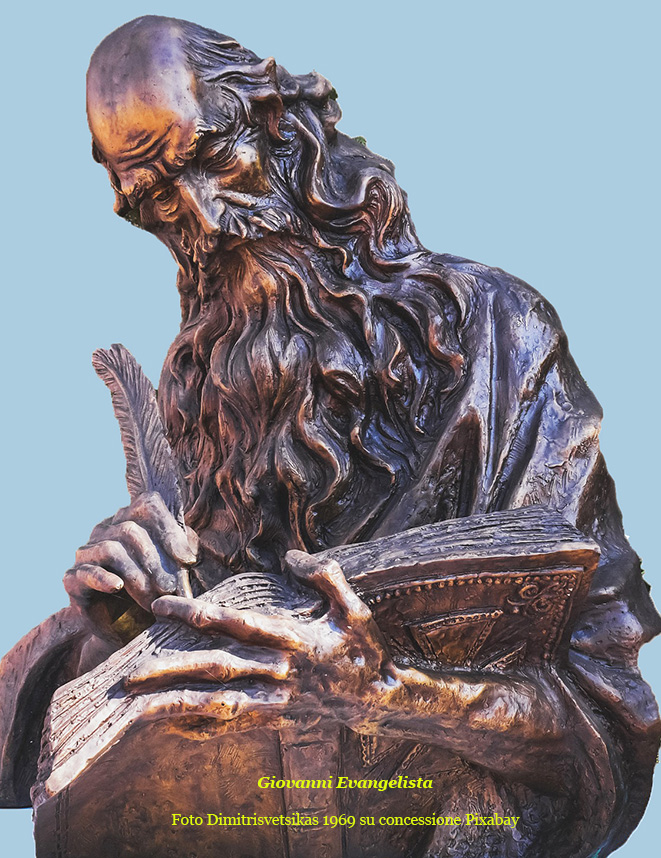 Il Vangelo di Giovanni
Il Vangelo di Giovanni
Lettura dei primi quattro capitoli
Introduzione
Molte persone mi hanno chiesto di parlare della Chiesa Giovannea, recentemente Marco Marsili mi ha fatto un’intervista sul significato di essa, quindi vi rimando al suo canale per poterla visionare.
Abbiamo spiegato cos’è la Chiesa Giovannea, cioè che non è una vera e propria Chiesa e non è una istituzione, però molti si chiedono tutte queste Verità Giovannee dove le troviamo?
Le troviamo nel Vangelo, quindi l’unica cosa da fare è proprio quella di prendere il Vangelo e di leggerlo, perché io credo che nel Vangelo di Giovanni ci sia la maggiore concentrazione di quelle verità che noi diciamo essere le Verità Giovannee.
Spero che vi innamoriate del Vangelo di Giovanni...
Che differenza c’è tra il Vangelo di Giovanni e gli altri Vangeli?
Io faccio sempre questo paragone: consideriamo un film in cui il regista deve far vedere una scena nella quale Gesù parla alla folla; seguendo i 3 Vangeli, Matteo, Marco e Luca, il regista farà una inquadratura su una gran folla e in fondo, lontano, Gesù che parla; invece nel Vangelo di Giovanni osserviamo una scena opposta, ci verrà presentato Gesù di spalle, oppure neanche sarà possibile vederlo, potremmo sentire solo la sua voce, e in fondo la gente raccolta ad ascoltarlo. Perché tutto questo?
Dialogo su "La Giustizia"

Dialogo su "La Giustizia"
Intervento conclusivo all'incontro, con l’arca di Varese, avvenuto il 15 novembre 2021
È stato una bella discussione nella quale avete espresso delle belle idee. Adesso per me è difficile mettere insieme tutto ciò che avete detto.
Vorrei partire dagli ultimi che hanno parlato perché penso che sia un modo più facile per partire.
Partiamo dal concetto della conoscenza e della consapevolezza.
Attraverso la conoscenza e la consapevolezza di chi siamo possiamo risolvere questo dilemma della giustizia.
La mistica presenza della grande madre dal velo di Maya al manto di Maria
 L’uomo ha sempre espresso la sua religiosità in qualsiasi tempo e in qualsiasi spazio dove ha trascorso il suo esistere. La religiosità non è la religione, sono esperienze individuali che parlano ai contemporanei, sono pratiche in cui si manifesta il sentire religioso, sono pratiche liturgiche o extra-liturgiche, preghiere, fustigazioni, digiuni, letture devozionali, testi che indicano i metodi di indirizzo, ma che non sono prescrizioni. Il “prescritto” è quello che la gerarchia ecclesiastica predica e inculca attraverso tutti i canali di comunicazione; il “vissuto” è ciò che viene interiorizzato da coloro ai quali quelle prescrizioni sono rivolte.
L’uomo ha sempre espresso la sua religiosità in qualsiasi tempo e in qualsiasi spazio dove ha trascorso il suo esistere. La religiosità non è la religione, sono esperienze individuali che parlano ai contemporanei, sono pratiche in cui si manifesta il sentire religioso, sono pratiche liturgiche o extra-liturgiche, preghiere, fustigazioni, digiuni, letture devozionali, testi che indicano i metodi di indirizzo, ma che non sono prescrizioni. Il “prescritto” è quello che la gerarchia ecclesiastica predica e inculca attraverso tutti i canali di comunicazione; il “vissuto” è ciò che viene interiorizzato da coloro ai quali quelle prescrizioni sono rivolte.
Ci sono dei momenti in cui la religiosità umana sembra trovare una espressione mistica quando l’azione religiosa sembra travolgere i concetti limitati del pensiero umano e travalica ogni sentire per immergersi nella perfezione cosmica, nell’anima stessa della creazione. Sono quadri storici del sentire religioso che segnano quanto sia vicino l’infinito alla limitatezza umana, il maestoso all’umiltà del sentimento, il cosmo all’imperfezione, il creato alla creatura.
Giovanni Battista secondo Matteo
 Ho sempre pensato che l'evangelista Matteo non fosse quel Levi, esattore di tasse, che Gesù ha chiamato a seguirlo. Sono consapevole che è solo una mia supposizione e che mai ho approfondito.
Ho sempre pensato che l'evangelista Matteo non fosse quel Levi, esattore di tasse, che Gesù ha chiamato a seguirlo. Sono consapevole che è solo una mia supposizione e che mai ho approfondito.
Questa idea però mi è ritornata in mente, rileggendo il Vangelo di Matteo nell'episodio in cui parla di Giovanni Battista. Ho avuto la sensazione di leggere un testo di una persona istruita e non di un semplice contabile arricchito, ma di uno che conosce la scrittura, conosce i metodi del racconto tipico ebraico della Torah e biblico in genere e che è ferrato nelle problematiche teologiche: insomma se non è un rabbi, è molto probabilmente uno scriba. Egli presenta un personaggio diverso dagli stessi altri due sinottici: il Giovanni descritto sembra conoscere chi è Gesù e quale sia la sua missione. Matteo per la sua composizione usa il Vangelo di Marco, ma lo mette in ordine e soprattutto lo fa con una visione teologicamente competente.
Perché Cristo deve ritornare

Ci troviamo a vivere in una situazione di tale sconforto generale che ci tocca ammettere che, con le nostre capacità fisiche, culturali e le risorse in genere, non siamo in grado di risolvere i problemi sociali, economici, ambientali e politici. Eppure è palpabile un gran desiderio di cambiamento: lo esige la gente, lo esige la natura, lo esige la concezione del sistema spirituale legato all’evoluzione cosmica del creato. Anche lo stesso rivolgerci al “Cielo”, per un suo intervento diretto, fa parte dello stesso sistema spirituale in cui la stessa anima umana è un mezzo di intermediazione tra l’umano e il divino. Molti uomini, scavalcando religioni e ideologie, invocano il cambiamento e si adoperano e si sacrificano per ottenerlo; le loro intenzioni, le loro grida e soprattutto le loro azioni, si uniscono in un unico fiume di energia della manifestazione umana che si trasmette alla manifestazione soprannaturale e da questa ricade forza divina fino al più misero degli uomini. “Nell'angoscia ho invocato il Signore, ho gridato al mio Dio, Egli ha ascoltato dal suo tempio la mia voce; il mio grido è giunto ai suoi orecchi.” (2Sam 22,7)
Il Precursore e i Testimoni del Ritorno

«Con la seconda sua venuta il Cristo conferma la vera natura divina di suo Padre Dio, il Creatore, che non è solo Amore, ma anche e soprattutto la Giustizia, vale a dire la manifestazione dell’ordine e dell’armonia dell’intero edificio cosmico. … “Cercate prima il Regno di Dio e la sua Giustizia” (Mt 6, 34). Questa frase avalla quanto noi abbiamo espresso precedentemente. Solo nel tempo dei Vangeli, per la stessa volontà del Padre, è stato permesso a Cristo di anteporre l’Amore alla Giustizia per aiutare gli uomini». È uno dei messaggi celesti comunicato allo stimmatizzato Giorgio Bongiovanni (“Il Ritorno”, pag. 37)
Nella logica creatrice, il Cosmo (in greco vale come “ordine”) posa sui due pilastri dell’ordine materiale e spirituale dell’Amore e della Giustizia. Questi due elementi sono incarnati nello stesso Verbo presente e attivo nella “Creazione” stessa: «In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.» (Gv 1, 1-3) Il Cristo e il Cosmo sono interconnessi, perché Egli lo crea, Egli l’organizza, Egli ne è l’anima che lo rende vivo. Ci sono nell’evoluzione sensibile due momenti: l’era dell’Amore e l’era della Giustizia. Nell’ultima evoluzione umana, prima che si crei il Regno, si sono i due tempi cosmici e cioè il periodo dell’Evangelo (era dell’Amore) e il periodo della Rivelazione, in greco Apocalisse, (era della Giustizia).
Pagina 1 di 6